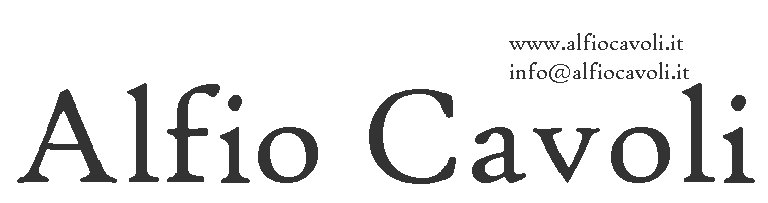 |
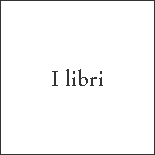
|
Paride Pascucci |
|
|
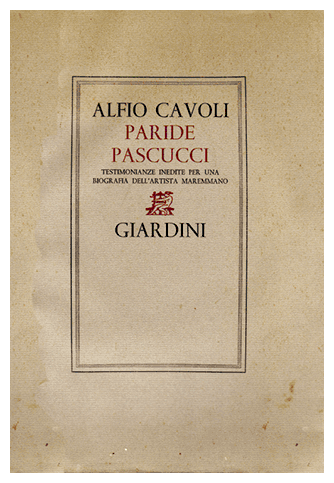
Testimonianze inedite per una biografia dell'artista
maremmano
Giardini Editori e Stampatori in Pisa,
Collezione di cultura, n.26
Pisa (1978)
pag. 43
 I
MODELLI I
MODELLI
 personaggi che Pascucci ha dipinto sono tutti reali,
veri autentici. Nessuno sfugge a questa regola dalla
quale l'artista non ha mai voluto prescindere, sia che
componesse quadri-denuncia pervasi di profonda tensione
drammatica, come «Eroi di Maremma», sia che traducesse
sulle tele tranquille scene di vita campagnola, come «La
sfogliatura del granturco». Ed è per questo che le opere
del Pascucci — al di là del loro valore artistico e del
loro messaggio sociale — costituiscono la fedele
rappresentazione, nel volto e nell'anima, di quella
povera umanità mancianese e maremmana (ma anche, per
analogia, siciliana, calabrese, lucana, per non dire,
senza far distinzioni, italiana) che conobbe uno dei
periodi più tristi della nostra storia.
personaggi che Pascucci ha dipinto sono tutti reali,
veri autentici. Nessuno sfugge a questa regola dalla
quale l'artista non ha mai voluto prescindere, sia che
componesse quadri-denuncia pervasi di profonda tensione
drammatica, come «Eroi di Maremma», sia che traducesse
sulle tele tranquille scene di vita campagnola, come «La
sfogliatura del granturco». Ed è per questo che le opere
del Pascucci — al di là del loro valore artistico e del
loro messaggio sociale — costituiscono la fedele
rappresentazione, nel volto e nell'anima, di quella
povera umanità mancianese e maremmana (ma anche, per
analogia, siciliana, calabrese, lucana, per non dire,
senza far distinzioni, italiana) che conobbe uno dei
periodi più tristi della nostra storia.
Gente realmente vissuta — tutta di estrazione
proletaria: braccianti, campagnoli, contadini — è dunque
riconoscibile nei lavori di Paride Pascucci. Cosicché
anche oggi — pur essendo ridotta al minimo la schiera di
coloro che sono in grado di ricollegarsi con vaghi
ricordi all'epoca più feconda del pittore — può
verificarsi il caso di sentir chiamare per nome e
cognome i personaggi rappresentati in questo o quel
quadro.
Una cosa, tuttavia, è indiscutibile: che ulteriori
ritardi nel determinare la loro esatta posizione
anagrafica — alla quale sono pervenuto partendo spesso
da indizi così insignificanti da rendere la ricerca
decisamente problematica — avrebbero impedito per sempre
a «Pasqualino della Streghina», a «Peppe sciorno», a
«Mecolino», di gettar via la maschera del soprannome per
rivelarci finalmente la loro vera identità. Forse,
portando a compimento una siffatta operazione di
recupero, ho rotto senza volerlo un incantesimo che si
sprigionava da certe opere pascucciane proprio per
essere legate a personaggi di questo tipo, quasi
circondati da un alone di leggenda. Ma ritengo che
l'iniziativa sia giusta nell'opinione dei più. Non si
poteva e — soprattutto — non si doveva correre il
rischio di condannare ad un perpetuo anonimato chi
collaborò con l'artista mancianese alla realizzazione di
«tele amorose» in cui — come si legge nell'epigrafe
dettata da Alfonso Giuliani in occasione del centenario
della nascita di Paride Pascucci — palpita «la spoglia
umanità degli umili / tenacemente curvi / su una terra
sdegnosa / nella scura e dolente epopea / che schiuse al
seme della vita / il seno amaro delle solitudini».
L'umanità di quegli umili che — immagini speculari di
una collettività reietta e disperata — si chiamavano,
appunto, «Mecardino», «Il cantoniere Pinzuti», «La
materassaia Nena».
[...]
|
|