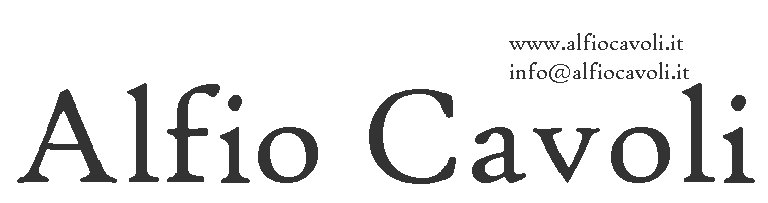 |
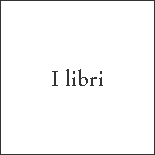
|
La Cartagine della
Maremma |
|
|
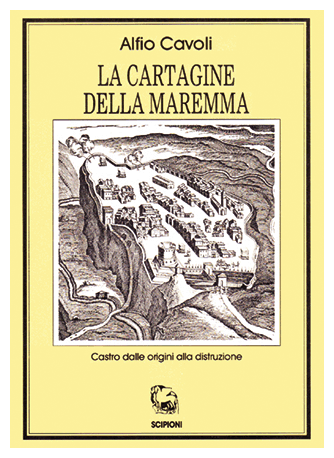
Castro dalle origini alla distruzione
Scipioni Editore,
Sturmundrang 7
Roma (1990)
pag. 91

 il 3 dicembre
veniva comunicata allo Spinola la "completa demolitione"
della città. il 3 dicembre
veniva comunicata allo Spinola la "completa demolitione"
della città.
Nel desolato pianoro che — alla luce della sconcertante
vicenda — si affacciava tragico sulle cupe depressioni
del torrente Olpeta e del Fosso delle Monache, sembra
che gli ultimi "becchini" della capitale farnesiana
erigessero una colonna di marmo con la scritta: QUI FU
CASTRO.
Ma di quella "fulminea" epigrafe, che rappresentava
l'espressione estrema dell'ira papale nei confronti di
una collettività d'infedeli, di eretici, di scomunicati
per l'uccisione del Giarda, non si è trovata mai traccia
né sui libri, né fra le poche testimonianze sottratte
alle macerie e all'invadenza disordinata della
vegetazione.
Una sola cosa sopravvisse, non lontano dal luogo del
misfatto pontificio, là dove un crocevia aveva
spalancato le sue braccia al viandante: un cippo con
l'immagine di Cristo dipinta due secoli prima e lì
collocata a invocare un sentimento religioso e una pace
cristiana di cui Castro raramente improntò la sua vita,
dilaniata come fu in ogni tempo dalle rivalità, dagli
odi, dalle lotte fratricide e dalle guerre fra potentati
che finirono col trascinarla nel vortice delle passioni
più velenose e violente e col farla precipitare
nell'abisso della perdizione.
Intorno a quel cippo, per iniziativa di Pio Baldaschi,
sorsero prima una cappellina e un altare (1847); poi —
nel 1870 — fu eretto il modesto Santuario che tuttora si
vede e che già nel 1852 una commissione di parroci
(Luigi Pasqualetti, Fabio Ziberi, Vincenzo Viti,
Domenico Mascini) aveva pensato di costruire.
Soffiando negli Anni Venti del nostro secolo sul fuoco
della fede popolare (e talvolta del bigottismo) il
vescovo di Acquapendente Tranquillo Guarnieri, il suo
delegato don Giuseppe Benigni e i vari curatori d'anime
della zona fecero sì che nel territorio si sprigionasse
— più ardente che nel passato — la grande fiamma della
venerazione di quell'antica effigie, a detta dello
Stendardi dispensatrice di cospicue grazie e di ripetuti
miracoli.
Cosicché, le invitanti domeniche di giugno videro
migliaia di pellegrini convergere — d'ogni dove — al
piccolo tempio sperduto nelle campagne castrensi,
recando nel cuore speranze — ai più negate — di vita
meno grama e di sospirata serenità familiare.
Giunsero invece — di nuovo — i giorni del terrore, degli
odi di classe, delle lotte fratricide, delle guerre
sempre più disastrose.
E furono ancora una volta violenza, distruzione,
desiderio di soppressione totale. Fu — ancora una volta
— Castro. Che, dopo tre secoli dal suo olocausto, ha
timidamente permesso al piccone — artefice del suo
disgraziato destino — di farsi riesumare in esigue
reliquie per dimostrarci quanto enorme sia stata la
spietatezza e l'inesorabilità di chi — per essere il
vicario di Cristo — avrebbe dovuto usare le sole, uniche
armi a lui consentite: quelle dell'umiltà, della
tolleranza e del perdono.

|
|