|
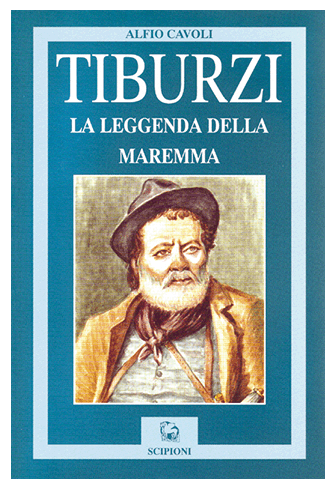
La leggenda della Maremma
Scipioni,
Valentano (VT) (1996)
Dipinto di copertina di Dino Petri.
Le foto riprodotte nel libro rappresentano alcuni momenti
scenici del film "Tiburzi" di Paolo Benvenuti*.
pag. 70
 Chi era più brigante?
Chi era più brigante?
 a leggenda dice che fu lui, Tiburzi, a provocare
quel colpo mortale. Per il tentativo che fece di estrarre
dalla fondina la sua pistola. Per il timore che suscitò in
qualcuno dei suoi segugi di essere ucciso. Ed è leggenda
davvero. Perché tutti sanno, ormai, che la verità non fu
quella. Perché a tutti è noto quale fu la verità. a leggenda dice che fu lui, Tiburzi, a provocare
quel colpo mortale. Per il tentativo che fece di estrarre
dalla fondina la sua pistola. Per il timore che suscitò in
qualcuno dei suoi segugi di essere ucciso. Ed è leggenda
davvero. Perché tutti sanno, ormai, che la verità non fu
quella. Perché a tutti è noto quale fu la verità.
La verità, ad esempio, è questa: che sembrano scomparsi
alcuni documenti fondamentali per stabilire con esattezza
come effettivamente si svolsero i fatti quella notte del
24 ottobre 1896, davanti alla porta delle Forane, nel
fango del piccolo recinto dove Tiburzi cadde falciato alle
gambe dal piombo dei carabinieri.
Oggi, la foto che l'Ulivi di Orbetello gli scattò
l'indomani, domenica, sul far del giorno, è diventata una
sorta di emblema di quella cruda pagina di storia
maremmana che fu il brigantaggio.
La si vede dappertutto: nei bar, nelle trattorie, nei
poderi, nei ristoranti.
Ed è incredibile che ciò avvenga, perché sono trascorsi
cent'anni da quando fu eseguita. Un secolo. E la memoria
del più famoso brigante della Maremma non solo non si è
minimamente affievolita, ma è tornata viva come negli anni
successivi alla sua scomparsa, quando nelle campagne il
nome di Tiburzi risonava sulla bocca del bifolco che
l'aveva imposto al più prestante dei suoi bovi, nelle aie
s'improvvisavano ottave sulla sua lunga, terribile
avventura, e i cantastorie facevano furore nelle fiere
paesane cantando le ballate che gli avevano dedicato.
Anzi, più viva ancora di quei tempi amari della condizione
contadina, dato che il giornalismo e l'editoria trattano
frequentemente della sua vicenda, il cinema e la
televisione ne rievocano le gesta (un film di Paolo
Benvenuti è in procinto di essere diffuso sia dagli
schermi televisivi che cinematografici) e i versi sono
tornati a fiorire sulle labbra dei poeti per ricordare
alle generazioni dell'era tecnologica – come fanno Mauro
Chechi, Silvana Pampanini e Mario Olimpieri – non solo
lui, le sue imprese, la sua contraddittoria esistenza di
ribelle sociale, ma anche la realtà di un mondo che non
poteva non partorire uomini resi indocili e vendicativi
dall'ingiustizia e dall'arbitrio. Palmiro Nardi, il
titolare della nota Trattoria "La Torre - Da Carla" di
Capalbio, ripropone – durante il 1996 – il menu "Per
ricordar Tiburzi", ovvero, com'egli ha detto, "il nostro
canto, la nostra poesia, che non è scritta ma è cucinata.
Come una volta e ricca di sapori, frutto e sapienza
contadina delle antiche tradizioni"; e si sta prodigando
per poter allestire, nella sede del Parlamento Europeo di
Strasburgo, proprio in concomitanza con le iniziative
tiburziane della Toscana e del Lazio, che potrebbero
essere utilizzate anche in quella città, una
mostra-esposizione dei prodotti tipici della Maremma.
L'Amministrazione Comunale di Orbetello programma un
convegno a livello europeo sul fenomeno del brigantaggio.
Ed altre manifestazioni di enti pubblici, quali spontanee,
quali coordinate dal caninese "Centro di documentazione su
Vulci e il territorio" sembrano ormai cosa certa.
E allora, per riprendere e concludere il discorso nel tono
iniziale, ci deve pur essere una buona ragione se tutto
questo accade; se la vita di un "volgare" brigante desta
un così diffuso interesse sia nella gente comune, sia nei
mass media che di tale interesse si rendono interpreti.
Una spiegazione può essere cercata e forse trovata in un
ragionamento semplicissimo, elementare, che, tuttavia, dal
punto di vista della verità storica, non fa una grinza;
questa: Sì, è vero, il brigantaggio fu una piaga infetta
sul corpo martoriato della Maremma, un bubbone difficile
da estirpare.
Ma era forse migliore, nel suo spietato egoismo, nella sua
costituzionale ingiustizia, nel suo intento vessatorio
della povera gente, la società che lo produsse e che non
fece nulla - proprio nulla - per creare le condizioni atte
a impedirne la nascita e la propagazione?
Tiburzi, è vero, aveva molte vittime sulla coscienza; ma
quanti omicidi, come minimo colposi, commise la nobiltà
agraria della Penisola in genere e della Maremma in
particolare sottoponendo le masse proletarie a lavori
estenuanti, "da stelle a stelle", per una paga vergognosa,
e alla mercè di caporaletti senza scrupoli che
pretendevano rendimenti impossibili con la persuasione del
nerbo?
Se leggiamo la storia e la cronaca del fenomeno che dilagò
specialmente nelle terre papaline (la seconda più
attendibile della prima) apprendiamo come l'uomo della
strada, il bracciante, il campagnolo, il contadino, si
schierassero spesso dalla parte dei fuorilegge,
condividendo i motivi della loro ribellione.
Così accadde per Federigo Bobini, per Tommaso Rinaldini
della Isabellona, per Stefano Pelloni, il "Passatore".
E così non poteva non accadere per Domenico Tiburzi, in
una terra, come la Maremma, dove un pugno di ricchi
blasonati, insensibili ai bisogni delle masse popolari,
faceva di tutto per inasprire, anziché mitigare, l'amara
esistenza dei deboli e dei diseredati. Ecco perché, forse,
è ancora tanto vivo il ricordo di "Domenichino" nel
microcosmo che lo vide imperversare per un quarto di
secolo: un ricordo che, probabilmente, prendendo lui come
punto di rifermento, è rivolto alla drammatica epopea dei
maremmani in un mondo di latifondi e di paludi che li
avvilì nella loro dignità di uomini, li straziò di
sacrifici e di fatiche, li divorò ("Maremma devorat
habitatores suos") con accanimento incessante e spietato.
Oggi, alla luce della verità storica, sono in molti a
chiedersi, alludendo a Tiburzi e ai responsabili della
società di allora, chi fosse più brigante. E tutti in
grado di darsi una facile risposta. 
*Film
del quale Alfio Cavoli è stato il consulente storico.
|
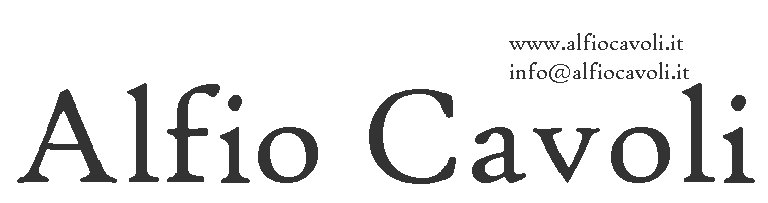
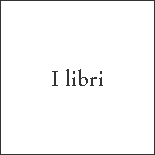
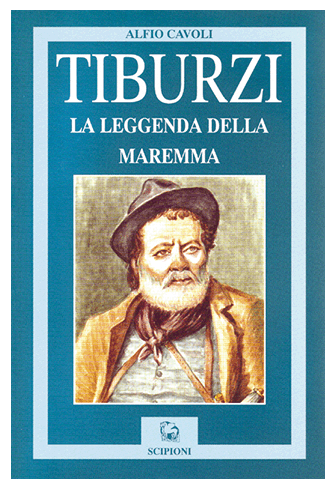
 Chi era più brigante?
Chi era più brigante? a leggenda dice che fu lui, Tiburzi, a provocare
quel colpo mortale. Per il tentativo che fece di estrarre
dalla fondina la sua pistola. Per il timore che suscitò in
qualcuno dei suoi segugi di essere ucciso. Ed è leggenda
davvero. Perché tutti sanno, ormai, che la verità non fu
quella. Perché a tutti è noto quale fu la verità.
a leggenda dice che fu lui, Tiburzi, a provocare
quel colpo mortale. Per il tentativo che fece di estrarre
dalla fondina la sua pistola. Per il timore che suscitò in
qualcuno dei suoi segugi di essere ucciso. Ed è leggenda
davvero. Perché tutti sanno, ormai, che la verità non fu
quella. Perché a tutti è noto quale fu la verità. 